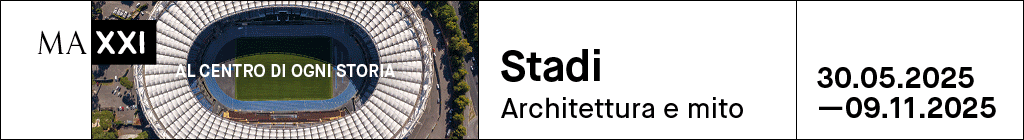Stadi e riqualificazioni, il vincolo non basta più
Riflessione sui progetti di recupero di impianti sportivi storici che, da Pescara a Bologna, coinvolgono molte città italiane
LEGGI GLI ALTRI ARTICOLI DELLO SPECIALE
Published 10 giugno 2025 – © riproduzione riservata
Gli interventi sugli stadi novecenteschi delle città italiane si rivelano spesso un vano tentativo di trovare il giusto compromesso tra istanze di tutela ed esigenze funzionali e commerciali.
Un processo con risultati spesso insostenibili
L’idea che le competizioni sportive e, in primis, il gioco del calcio, debbano svolgersi in impianti adeguati alle normative in vigore e alle odierne esigenze di carattere tecnico, urbanistico, gestionale, commerciale, è certamente degna della massima considerazione.
Tuttavia, pur nella diversità dei luoghi urbani, delle circostanze contingenti, degli stessi soggetti responsabili, le soluzioni prospettate finiscono con il riproporre i medesimi obiettivi di compromesso, con risultati spesso insostenibili.
Di fronte al dilemma se realizzare un nuovo impianto su suoli vergini, ai margini del concentrato urbano oppure riadattare gli stadi esistenti, testimoni delle vicende non solo sportive delle città che li accolgono, si opta sempre su quest’ultima possibilità.
Senza considerare – visti i risultati – che la maggior parte degli stadi italiani realizzati tra gli anni ’20 e ’60 del Novecento costituiscono un segmento identitario del patrimonio nazionale caratterizzato, in generale, da organismi che, senza alcun mascheramento, esibiscono la struttura e i materiali costruttivi come architettura, dando luogo a un vero e proprio linguaggio, al contempo tecnologico ed espressivo.
Il caso emblematico di Nervi a Firenze
I casi sono innumerevoli. Ricordiamo il Renato Dall’Ara a Bologna, in origine “Littoriale”, con il doppio ordine di arcate in mattoni a faccia vista, tipici dell’architettura emiliana, e le strutture in cemento armato che contrassegnavano la modernità dell’invaso interno.
Realizzato nel 1926 su un’area di 130.000 metri quadrati a spese del partito fascista bolognese col pensiero al Colosseo, vincolato dal Ministero nel novembre 1986, fu oggetto di interventi in vista dei Mondiali del 1990, su progetto di Enzo Zacchiroli, Piero Fossati e Franco Zari con telai in acciaio che non avrebbero occluso la struttura in mattoni.
L’ultimo progetto del 2019, di Gino Zavanella, non prevede la demolizione del Dall’Ara, ma prospetta un nuovo stadio nello stadio e una copertura in alluminio che, di fatto, cancellerebbe il complesso originario.
Né a miglior sorte sembra andare incontro lo stadio Artemio Franchi a Firenze, opera di Pier Luigi Nervi che, nel progetto di David Hirsh e ARUP Italia, pur se restaurato, sarebbe sormontato da una copertura sovradimensionata; l’invaso interno originario sarebbe cancellato alla vista, anteponendo nuove gradinate a quelle esistenti; i nuovi sky-box cancellerebbero la partenza delle mensole a sbalzo che reggono la copertura della tribuna; le strutture che ne qualificano l’immagine verso la città sarebbero relegate in secondo piano, visibili solo per parti e da angolazioni e distanze obbligate, come se fossero materialmente smembrate e disarticolate; i chiaroscuri sulle strutture in calcestruzzo, cangianti sotto la luce naturale, sarebbero cancellati; le scale elicoidali che sembrano arrampicarsi verso il cielo, sarebbero occluse dall’intradosso metallico della nuova copertura; e completamente alterati i rapporti col contesto urbano e con quello paesaggistico. Attualmente è in corso il primo lotto di intervento, relativo principalmente alla curva Fiesole.
Serve una strategia generale
Potremmo citare altri casi, come quello del San Paolo, poi Maradona a Napoli, o quello del Meazza, poi San Siro a Milano; o, ancora, lo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, realizzato su progetto di Luigi Piccinato tra il 1954 e il 1957, integrato da un secondo anello dallo stesso Piccinato nel 1977 e vincolato dal Ministero: anch’esso oggetto di un progetto che lo trasformerebbe in centro commerciale.
Oppure la paradigmatica situazione, in recente evoluzione, del Flaminio a Roma. Una situazione per certi versi analoga caratterizza lo stadio Sinigaglia, a Como, pur vincolato dal Ministero nel 1988, per il quale lo scorso febbraio è stato presentato un primo concept di progetto che altererebbe irrimediabilmente non soltanto lo stadio, ma anche il delicato contesto naturale in cui è inserito, tra i giardini e il lago, qualificato da altre opere appartenenti al patrimonio nazionale, quali il Monumento ai Caduti, ispirato alle visioni di Antonio Sant’Elia, la Casa di Balilla, la Casa Giuliani Frigerio, il Novocomum, la sede della Canottieri Lario.
In conclusione, crediamo che tra mercato e tutela, sempre più, intercorra un dialogo tra sordi e che l’attuale strumento del vincolo, soprattutto in situazioni contrassegnate da forti interessi economici, non sia adeguato agli scopi della tutela, che devono confrontarsi con dinamiche complesse, spesso riferibili ad altri più pervasivi e autonomi ambiti disciplinari quali, oltre all’economia, la politica, la sociologia, la stessa carente e contraddittoria giurisprudenza.
Il dialogo andrebbe reimpostato a monte, su un piano generale e normativo che possa costituire un riferimento coerente per le singole situazioni.
Immagine di copertina: Pier Luigi Nervi, Stadio comunale G. Berta, Firenze 1932, courtesy Fondazione Maxxi nell’ambito della mostra “Stadi. Architettura e mito”, 2025, Roma, Collezione Architettura e Design contemporaneo, Archivio Pier Luigi Nervi

Nato a Napoli (1948), vi si laurea in Architettura nel 1973. Direttore presso la Soprintendenza BAP di Napoli e provincia dal 1979 al 2013 e Soprintendente reggente nel 2000. Componente del comitato tecnico per il Piano nazionale per gli archivi e l’architettura del Novecento del MiBACT (2001-2013). Membro del comitato scientifico dell’Associazione Dimore Storiche – Campania. Presidente di Do.Co.Mo.Mo. Italia ONLUS. Autore di numerosi restauri e di allestimenti di mostre di architettura e arte. Premio ex-aequo al concorso per progetti pilota per la conservazione dei monumenti tra Paesi membri CEE con il progetto per la chiesa di Sant’Aniello a Caponapoli (1988). Dal 1996, docenze a contratto presso l’Università degli studi di Napoli Federico II, la Seconda Università degli studi di Napoli, l’Università degli studi della Basilicata e l’Università degli studi Suor Orsola Benincasa. Tra le principali pubblicazioni recenti: “L’area metropolitana di Napoli. 50 anni di sogni utopie realtà” (curatela con M. Visone; Napoli 2010); “Maledetti vincoli. La tutela dell’architettura contemporanea”, Torino 2012; “Time Frames: Conservation Policies for Twentieth-Century Architectural Heritage (curatela con M. Visone; Londra-New York 2017)