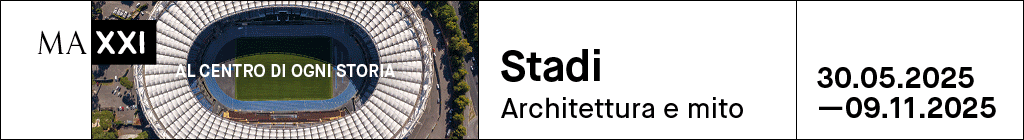Apprendere accessibilità e inclusione
Formazione, ricerca e iniziative innovative nella riflessione di Iginio Rossi, coordinatore Community INU Città accessibili a tuttə
Published 17 ottobre 2025 – © riproduzione riservata
I “titolari” della rete Apprendere accessibilità e inclusione sono tutti i soggetti che ritengono di avere qualche cosa di interessante da dire relativamente al tema. La nuova rete ha la finalità di sviluppare un ambito interdisciplinare di confronto, dibattito e aggiornamento sui temi dell’accessibilità universale e dell’inclusione cercando di ridurre la carenza estesa che purtroppo contraddistingue la realtà italiana in cui l’accessibilità universale è diffusamente trattata come ambito settoriale, specialistico e che riguarda solo i “disabili”.
Promossa dall’INU, Istituto Nazionale di Urbanistica, la nuova rete è un’iniziativa articolata in tre fasi dalla Community “Città accessibili a tuttə” che prosegue il lavoro e l’impegno avviati nel 2016 e che in questa stessa iniziativa coinvolge la BISP, Biennale dello Spazio Pubblico, Urbanpromo, la manifestazione di riferimento per la rigenerazione urbana di Urbanistica Italiana, e che vede la collaborazione di INU Giovani e CERPA Italia ETS ma anche il patrocinio di Design for All Italia.
La prima fase, che è stata conclusa, riguarda la costituzione della rete che ha preso forma in occasione della BISP, Biennale dello Spazio Pubblico a Roma, con un seminario svoltosi il 19 settembre 2025 al quale hanno partecipato gli aderenti alla call per abstract lanciata nel marzo 2025. Nel workshop della BISP attraverso la metodologia dei “tavoli” si sono confrontati, condividendo le loro esperienze, una trentina di soggetti tra docenti e ricercatori di diverse università italiane, professionisti e rappresentanti di pubbliche amministrazioni nonché appartenenti ad associazioni del terzo settore, hanno delineato le azioni della nascente rete che agiscono sui temi della formazione, della ricerca e dell’innovazione. I materiali raccolti grazie alla loro eterogeneità – uno dei pilastri dell’accessibilità universale sta proprio nella diversità degli approcci, dei punti vista e delle motivazioni dai quali proviene la principale risorsa per visioni multiscalari e “aperte” – hanno consentito di tracciare gli ambiti di lavoro. Divulgare l’inclusione, integrare processi per l’inclusione, politiche per l’inclusione e ricerca-territori: questi i raggruppamenti all’interno dei quali vengono sviluppate le prospettive per implementare contenuti e componenti della rete.
La seconda fase, attualmente in corso, prevede un incontro all’interno di Urbanpromo, in programma a Firenze il 13 novembre 2025 nel pomeriggio presso l’Innovation Center CRF, Apprendere Accessibilità e Inclusione – Edizione 2025. Nell’occasione saranno approfonditi i temi della qualità, dell’attrazione e dell’efficienza dei territori. A partire da alcuni casi, raccolti dalla call, verranno affrontati aspetti interconnessi: l’apprendimento, con attenzione alle dimensioni individuali e collettive che incidono sulla vita, sull’autonomia e la libertà delle persone; la qualità, l’attrazione e l’efficienza di territori, patrimoni culturali, con particolare attenzione ai Siti Unesco, città e abitare; i livelli di accessibilità universale.
La terza fase vedrà, realizzata da INU Edizioni entro la fine dell’anno 2025, l’uscita della pubblicazione digitale “Apprendere accessibilità e inclusione” contenente i paper pervenuti alla call e selezionati dal Comitato scientifico, in formato open access con codice ISBN .
L’accessibilità universale e l’inclusione sono diritti essenziali che trovano riferimenti: nella legge costituzionale articolo 3. Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006; nell’Agenda 2030, proposito 11.7: “nel 2030 sarà necessario assicurare un accesso universale per degli spazi pubblici e verdi che siano sani, inclusivi e accessibili, in particolare per le donne e per i bambini, per le persone anziane e per le persone con disabilità”; nel D.Lgs. 222/2023: disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità. Nel complesso riguardano tutte le persone, sono un sistema interconnesso, multiscalare, multidisciplinare. Devono garantire le qualità essenziali al soddisfacimento delle aspettative/richieste, e soprattutto l’accessibilità universale non può essere affrontata con approcci o strumenti settoriali e separati: è un “sistema integrato”.
Le persone sono la vita delle città, le città sono fatte da connessioni, le connessioni sono alla base dell’inclusione, l’inclusione libera le persone, le persone sono la vita delle città. La concatenazione assume un valore olistico introducendo in ogni passaggio anche il traguardo del benessere per tutte le persone. Una circolarità incrementale che determina il progressivo miglioramento della qualità della vita nell’abitare città e territori.
Tutto ciò in teoria ma nella pratica no. Le inefficienza sono articolate, per citare le più significative, si riferiscono agli spazi pubblici e a quelli privati che escludono; appartengono alla sfera personale e collettiva segregando; alzano barriere sugli aspetti fisici, sensoriali e percettivi; rimandano alla cultura, al sociale, alla sanità e all’economia creando marginalità e fragilità; implicano le difficoltà di fruizione delle infrastrutture legate ai servizi, della mobilità e più in generale dell’abitare. L’accessibilità dovrebbe essere invece un sinonimo di vitalità.

Le prospettive di lavoro della rete
Didattica per l’inclusione. Il monitoraggio delle attività delle Università nei confronti di studenti con disabilità, esperienze didattiche, corsi ad hoc, attività di II livello orientate alla definizione di strategie di progetto per territori, città e abitare. A titolo esemplificativo, si tratta di corsi sull’accessibilità degli spazi pubblici, del patrimonio culturale, della mobilità, sulle barriere dei cambiamenti sociali, economici e climatici, di master progettuali, di politiche nei confronti di studenti e studentesse con disabilità.
Politiche per l’inclusione. L’organizzazione di attività, finalizzate a diffondere e a comunicare, legate a un coinvolgimento allargato di stakeholder e portatori di interesse. A titolo esemplificativo, si tratta di casi di costruzione della consapevolezza attraverso pubblicazioni anche multimediali, percorsi partecipati e di ascolto, di campagne orientate all’eliminazione e alla riduzione delle barriere, alla creazione di percorsi inclusivi riguardanti il turismo per tutti e lo sport.
Formazione e divulgazione. Iniziative di coinvolgimento della pubblica amministrazione, delle istituzioni, degli enti di categoria disciplinari, dei soggetti socioculturali indirizzate alla costruzione e al rafforzamento di politiche integrate. A titolo esemplificativo, si tratta di corsi di aggiornamento professionale, di azioni mirate all’inclusione sociale, di esperienze di co-progettazione, di previsione di strumenti integrati per la qualità della vita e il benessere.
Ricerca e territori. Azioni legate all’utilizzo di metodologie e strumenti di carattere innovativo. A titolo esemplificativo, i casi di nuove tecnologie a sostegno dell’autonomia, della migliore qualità del benessere e della sicurezza delle persone negli ambienti di vita collettiva e privata, di applicazioni progettuali inerenti servizi di trasporto, edifici e spazi domestici, edifici pubblici o aperti al pubblico, ambiti urbani, strade, parchi pubblici, spazi polifunzionali.
Soggetti che hanno aderito alla rete (aggiornamento 15.10.2025).
Docenti e ricercatori delle Università: degli Studi della Basilicata; Bergamo; Cagliari; Ferrara; Firenze; Lund University; Napoli Federico II; Perugia; Politecnico di Milano; Salerno; Trieste; Udine.
Rappresentanti di: Codesign Toscana ETS; Consiglio Nazionale delle Ricerche; Collettivo Architutti; Fondazione Architetti di Firenze; Spazio Geco Società Cooperativa.
Rappresentanti di: Centro regionale accessibilità della Regione Toscana; Comune Città di Castello; Comune di Genova; Unione della Val d’Enza.
Immagine di copertina: il seminario del 19 settembre 2025 alla BISP a Roma. Attraverso la metodologia dei “tavoli” ha posto a confronto una trentina di esperienze eterogenee dalle quali sono emerse le prospettive di lavoro della nuova rete Apprendere accessibilità e inclusione (© Iginio Rossi 2025)
Coordinatore Community INU Città accessibili a tutti.